 Valensole
Valensole
Mi ero ripromessa di preparare qualcosa.
Non ci avevo pensato, in un primo momento, non ci avevo creduto. Ero forse convinta che sarebbe arrivato così, l’idea giusta, quel qualcosa e basta. O semplicemente non mi ero accorta che fosse così vicino.
Perduta, del tutto perduta fra i miei pensieri. Sogno d’altro, e dimentico.
Mi fa male? Non so. Questo essere sbadata, ogni ora sempre un tantino di più, ha il sapore dolce di una torta che si costruisce pezzo pezzo, a strati. Oggi cuciniamo la base, domani il primo livello, poi passiamo alla glassa…
Squisitamente dipinta al cioccolato.
Un anno fa vi ho narrato la storia di un guerriero. Da allora, ha combattuto tante battaglie, e mi ha salvato innumerevoli volte dalle fauci di un triste fato.
Non saprei più che dirvi di lui.
E non ho niente. Fra le mani, petali di… di crisantemi, frutto del mio giardinaggio scellerato.
E una tragica brezza di nostalgia che entra dalla finestra, spalancata sul vuoto del domani.
Forse provo a chiudere gli scuri.
«Chiudi gli scuri, Evangeline.»
Forse stavolta lo faccio davvero.
E… e buon compleanno, solo questo. Scusami se non ho potuto essere all’altezza di tutto.
Così nasce il mio primo sonetto… una prova – venuta male. Se qualcuno ne capisce qualcosa di metrica, potreste dirmi se è giusto? Merçi ^^

Forse non arriveremo a sapere
Perché il vento ci sta trascinando
Per lande su ali veloci e leggere
Di campi infiorati va sussurrando.
E che motivo angustioso noi abbiamo
Per rimanere immersi nei ricordi
Se arte si cosparge di cinnamomo,
Nastri scarlatti e sapore di fiordi…
Accompagnami verso altre nazioni,
Fuggiamo! Via da dolori e tormenti.
Alle lavande in sboccio importerà se
Pianteremo anche mandorli e soffioni?
Ci feriremo solo coi frammenti
Di porcellana sul piattino da tè.
 I Can Wait Forever, Interludio VII
I Can Wait Forever, Interludio VII
Fine del primo interludio. Negli ultimi paragrafi si consuma una scena da target arancione.
Edit: è il mio centesimo post. Buon compleanno, caro blog.
Nessuno li ha visti, nessuno ha parlato di loro, non una figura umana che s’interessi di cosa si stia consumando in quella stanza, ove ogni sera vi si sprangano, con il clangore di una serratura che mette a tacere ogni voce. Può un lutto serrare le bocche di qualsiasi individuo? L’arte del silenzio è il frusciare delle ombre. Le tende che s’aprono e si riversano da una finestra discosta: un fruscio.
«Lo soffri, eppure continui ad amare il freddo. Chiudi gli scuri, Evangeline.»
Una veste cala a terra, dopo che i lacci che racchiudevano il tutto – è lo schiudersi di un fiore, il dilagare di ogni emozione – sono stati sciolti da una mano rapita dal fremito dell’incoscienza. Le gonne turchesi prendono le forme di una distesa marina, una polla sull’aldilà che frantuma la monotonia del gelido marmo. Da esso, spunta una sirena dai capelli dipinti di sorbo. Dietro un paravento di fine carta vermiglia, una voce risponde: «Non ancora.»
Non ancora. Aspetta lì, Byron, sdraiato sul letto, lo sguardo triste e pensoso, la camicia sbottonata tanto che basta a far affiorare la pelle del cuore. Questo batte, bussa alle porte del desiderio, mentre lo sguardo rifugge dalle zone buie di un corpo nudo, un mimo perfetto, nascosto. Il sussurro della seta che lo riveste trascina con sé un muto grido, la dolcezza del suo suono è paura, sconcerto, indulgente disperazione. Le mani di lei annodano un fiocco dietro la schiena per stringere la vita in un abbraccio sottile.
Evangeline esce, i piedi nudi che calpestano il pavimento come se stessero galleggiando fra petali di rose, tra le braccia l’impacco maldestro del vestito da giorno, il mare che l’ha partorita. La vestaglia si ferma più su del ginocchio, ed è tenuta in cima da due fettucce rosse così come il tessuto. Si è sbrogliata i capelli, le ricadono sulla schiena in un rivolo di ciocche dalle sfumature ramate.
«Chiudi gli scuri, Evangeline. Prenderai freddo» insiste.
Fa finta di non sentirlo, getta l’abito su una poltrona azzurra e si avvicina al letto. L’alcova ha un soffitto intelaiato a fiori color orchidea e lampone, le cui foglie vanno a creare un manto intricato d’arabesque. Sui colonnati si sparpagliano motivi d’edera e malve intrecciate.
Lei gli poggia un dito sulle labbra quando questi fa per protestare, accostandosi al suo volto. «Voglio farti vedere una cosa.»
S’inginocchia e rimesta con un braccio sotto al baldacchino, alla ricerca di qualcosa. Quando ne riesce, ha in mano la sua valigia da disegno. Le borchie che ne costringono gli angoli sono ammaccate e scurite, il cuoio nero graffiato, caduchi protagonisti di viaggi e mostre, arti e lavori. La apre, e i ganci che ne legavano il contenuto scattano via all’unisono.
Una manciata di fogli si riversa a terra. Tutti i colori con cui dipingeva le anime del mondo, i barattoli in cui intingeva ogni emozione, i pennelli unghiati e sempre pronti a graffiare la tela, sono tutti spariti. Solo pagine, carte, pergamene – ogni tonalità capace d’accogliere tratti di grafite – è ciò che si scaglia sul pavimento come il getto di una fontana: un fruscio. Si nascondono per l’impiantito, piastrelle scalfite di volti e reami lontani, specchi che danno su una realtà distorta dall’effluvio di un incantesimo.
«Ma…» sfugge dalle labbra di Byron, più un suono impercettibile che un reclamo vero. Non lascia le coperte, ma ne infiora di pieghe infervorate la superficie liscia, le sue dita strette ad afferrare il tessuto.
«È tutto a posto» dice la donna. Si china a raccogliere il primo che ha toccato il suolo, lo tiene vicino al petto per non farne vedere il contenuto all’amato, è una bambina che protegge la sua bambola preferita stringendola al seno. Si siede appena sotto il bacino di lui, lasciando che le sue mani l’abbraccino, quindi rivolta il disegno perché lui possa osservarlo.
I colori sono sprazzi intonsi di luce su una scena dominata dal nero. Per una volta Evangeline non si è dedicata alle tenui tinte degli acquarelli, ma ha usato pastelli oliati per generare il fascino di un distacco infelice. Una, due, cinque spighe di lavande dai riflessi vitrei sono poggiate su un pianoforte verticale, e i tasti s’incavano sotto la loro premurosa pressione. La melodia delle terre di Provenza si sparge sugli spartiti appena sbozzati.
«Bianco, nero, bianco, bianco…» sussurra lei.
Il dipinto è ripreso di profilo, e si vede la figura in ombra di un uomo, seduto su uno sgabello di fronte allo strumento. Le braccia sono abbandonate sui fianchi, in un atto di mesta rinuncia, e gli occhi socchiusi paiono fremere allo sfiorare di ricordi distanti nel tempo. Un piede è poggiato sul pedale, quasi a voler spingere quel suono a non smorzarsi, a durare finché anche il destino non ne avrà tracciato una fine sicura.
È tutto buio, è la coltre della morte che si distende e si rivela sullo sfondo sfumato: una tenda bianca, così sottile che si intravede da essa l’infinità di un cielo stellato, e così pieghettata su se stessa, sgualcita, che le sue crespe formano un altro volto, femmineo, contrapposto a quello del giovane.
Il viso etereo si protende verso di lui, le labbra schiuse in un bacio consolatorio. E si sa, ora, che la macchia biancastra che rischiara parte della guancia del ragazzo è in verità una mano di fumo, una carezza proveniente dalle distese di un territorio sconosciuto. Vaucluse, non sei mai stata rifugio più bello.
«Non l’avevo finito. Non volevo mostrartelo prima, ma ora… ora era il momento giusto.»
«Sono io» constata Byron. Oramai il foglio giace fra le sue dita, gliel’ha strappato per perdersi fra i ricami della sua vita, coinvolta in una bozza piccola, inferma, delicata come la sua esistenza ora riposa appesa a un filo. E la lascia, inutile pergamena – che scivolasse pure in terra fra le sue compagne di carta. Si dimentica, nella notte, ciò che affolla le vie del tormento.
Prende Evangeline fra le braccia e la porta a stendersi su di sé. I primi baci si consumano nella disastrosa quiete di un segreto sussurrato troppo forte, nella bramosia di cadere vittime dell’ardore. Il gelo che proviene dalla finestra aperta è divenuto brezza piacevole, aria fresca da concedersi in respiri affannosi.
Byron fa scivolare le labbra sul collo della donna, percorrendone la pelle con la leggiadria di un accordo, e brividi di piacere scuotono il corpo di lei. La spallina le ricade sul braccio, mentre la bocca dell’uomo si muove lungo la spalla e scende, cauta, a liberarla da ogni pudore. Il giovane accoglie il suo seno turgido, pervaso da un profumo più caldo e tenero, che si scontra con la sua lingua ansiosa.
Più in basso, le mani di lui raccolgono la vestaglia in spire che sono il cristallizzarsi del volo di una farfalla, onde marine permeate da un sapore vermiglio, e in una carezza che sfiora i fianchi di lei porta il tessuto a cedere dalla carne.
Dita d’artista slacciano gli ultimi bottoni della stropicciata camicia di Byron, sfilano i calzoni di velluto marrone; a far compagnia ai sogni di lei dispersi al suolo, si aggiungono le vesti portate via con insofferenza. Un fruscio, e non è più silenzio.
«Ti prego, scappiamo incontro alle lavande in sboccio» lo implora lei.
E si chiude così, come se nulla fosse mai accaduto, un velo che si stende sulla fulgida superficie del mare… un bacio di luna per gli immigrati del cielo.
 I Can Wait Forever, Interludio V
I Can Wait Forever, Interludio V
Dico solo questo: ci stiamo avvicinando a una svolta.

07/03/1823 – Interludio
Londra, Casa Hinchinghooke.
Il suono delle posate d’argento è lo straziante requiem dei cuori soli. Poche parole, solo quelle più necessarie, l’imbarazzo dell’infanzia perduta e delle memorie comuni: non v’è alone di consolazione, solo triste e immutata condivisione del dolore.
La composizione di frutta, nel vassoio al centro, pare attendere l’artista che ne dipingerà i tratti, con cauta lentezza e studio d’ombre. Giorno dopo giorno, aspettando l’ora del primo mattino, resterà lì a impolverarsi e a rinsecchirsi, finché di essa non rimarrà che un’immagine senza sapore.
I piatti sono pieni di ricordi, vuoti di cibo. I ghirigori attorno ai bordi, sapientemente dipinti da mani esperte, giacciono nella loro tenue tonalità salmone, e si tengono forza, filamento per filamento, lì a sospendersi in un cerchio nel bianco della porcellana.
Una domestica interrompe la quiete, portando un cesto di pane appena sfornato, caldo, poi tiepido, poi abbandonato a raffreddarsi intonso. È entrata da una porticina in legno, secondaria, con un intaglio in vetro nella parte alta che tuttora è appannato dai fumi della cucina. Quando rientra, l’uscio si richiude facendo vibrare l’argenteria accuratamente lucidata negli armadi a vista, con uno scampanellio che si riversa fra i vetri delle ante e dei ripiani.
«Quali sono i vostri programmi per la giornata?» Chiede Evangeline. Ha un segno sotto l’occhio sinistro, come una piega lasciata dal segno di un cuscino – un sogno interrotto, e le palpebre appena schiuse di chi è desto ma assonnato. Offre un sorriso prudente ai tre uomini che siedono alla tavola rettangolare.
Il più giovane, che le siede di fronte, prende un tovagliolo e se lo tampona sulle labbra. «Io e Delbert saremo fuori fino a stasera» dice, indifferente, quindi si passa le dita fra i capelli biondo cenere raccolti in un codino.
L’altro, seduto alla sua destra, annuisce con fare intento. Si dondola sui piedi della sedia, portando lo schienale in un’angolazione impossibile. Le labbra rosee come quelle di una fanciulla hanno una piega orgogliosa, carica di una dignità affetta dal risentimento. A ritmo del suo dondolio, le tende rosa pesco piegano in numerosi sbuffi da una delle vetrate, confondendosi al raso bianco dei veli più sottili e irrompendo nella sala da pranzo. Una finestrella è stata lasciata aperta per rinfrescare l’ambiente.
«Eva, che ne direste di prendere una boccata d’aria? La colazione è terminata, non c’è bisogno che ci tratteniamo più del dovuto. Sono certo che anche i miei fratelli abbiano le loro incombenze da svolgere» propone Byron e le prende una mano da sotto il tavolo, sgusciando fra i riccioli merlettati della tovaglia chiara, raggiungendola in uno spasimo d’amore.
Lei arrossisce, accorgendosi della sua impudenza, e con un cenno del capo che s’avvicina a un inchino si accommiata dai due: «Vi auguro di trascorrere una bella giornata.» Il suo sguardo si sofferma un istante in più su Delbert, che però non risponde, scuote soltanto la testa, lasciando che i ricci castani gli coprano parte del volto.
Mentre si allontanano, il parquet ricoperto dal tabriz persiano attutisce il ticchettio delle suole, il cui ritmo si uniforma a un solitario pendolo nell’angolo. Tic-tac, tic-tac, è anche il rumore dei telai che tessono fitti orditi nelle terre d’oriente.
Byron la trascina in giardino, attraverso una vetrata scorrevole che vi s’immette direttamente dalla stanza. Una ventata fresca li investe al primo impatto e la giovane rabbrividisce.
«Volete che rientri per prendervi una cappa?»
«No, Byron, non ce n’è bisogno. Sto bene così.»
 Il prato fruscia sotto i loro passi sommessi, l’erba che si piega in dolci onde e che si rialza, carezzando le caviglie con un bisbiglio inudibile. Nel vialetto di pietre, fra un masso levigato e l’altro, sono cresciuti sparuti mucchi erbacei, da cui spuntano boccioli di timide primule. Il fiore giustifica i mazzi.
Il prato fruscia sotto i loro passi sommessi, l’erba che si piega in dolci onde e che si rialza, carezzando le caviglie con un bisbiglio inudibile. Nel vialetto di pietre, fra un masso levigato e l’altro, sono cresciuti sparuti mucchi erbacei, da cui spuntano boccioli di timide primule. Il fiore giustifica i mazzi.
Il sentiero conduce, con una lieve salita, a un ponte in legno, con dei sostentamenti di ferro leggermente arrugginito ai bordi. Sotto la passerella gorgoglia un rivolo d’acqua pura, che si colora dei riflessi verdini della natura appena inselvatichita che lo circonda.
«Vi è sempre piaciuto, questo posto. Nelle primavere, bevevate l’acqua a lunghe sorsate, senza preoccuparvi delle macchie d’erba che vi sporcavano il vestito. Vi inginocchiavate lì, fra le libellule, pronta a spiccare il volo.» Indica una conca sabbiosa che immette gradatamente al rio, ampio in quel tratto non più di un paio di braccia. Per tutto il tempo non le ha mai lasciato la mano, e ora che sono saliti sul ponticello, il legno geme contrito ad ogni spostamento di peso.
«E tu mi trascinavi lontano, perché temevi che sarei potuta scivolare in acqua, nonostante il torrente sia poco profondo. Mi portavi sul ponte…»
«Vi bloccavo il corpo contro la balaustra che in estate gettava foglie di rampicanti a sfiorare le rive sotto di loro.»
«Come stai facendo ora.»
«E vi…» Una mano lo blocca, fermandosi sulle labbra di lui. Un paio d’occhi azzurri, intimoriti, bagnati di lacrime sospese sull’orlo dell’abbandono, si fissano in quelli dell’uomo. È una preghiera muta che induce al silenzio.
È il sussurro: «Smettila di darmi del voi. Ti prego, Byron, non posso sopportare più questo tuo lasciarmi indietro, lontana da te.»
Lui ride, poco più che un andirivieni, un tintinnio di felicità cosparso nell’aria. La condensa che spira dalla sua bocca, ora aperta, strascica fumi che velano vascelli d’intimità, vascelli di carta, con le ali ripiegate lungo le fiancate.
«E ti dicevo che eravamo solo un sussurro. Un sussurro nel vento, e che presto saremmo volati via con esso, danzando su quei piani impalpabili di una passione che ci allenta e poi restringe i nostri corpi in un tango che è veleno d’amore, scorre nelle mie mani intrecciate alla tua schiena e…»
E s’infiorano ali d’argento che trasudano disperazioni imperlate dal vuoto che li separa. Un respiro, due, è un sospiro che si trasforma in ordine e muta in piacere.
«E voleremo più giù, più su, più in fondo. Ove non si fa ritorno.»
 I Can Wait Forever, Interludio III
I Can Wait Forever, Interludio III
Lo so che conoscere la storia a spezzoni, saltando da un blog all’altro, è un po’ scomodo. Vi chiedo solo d’avere pazienza. Procediamo veloci, e in ogni caso potete sempre ricorrere alla pagina creata apposta per fare meno confusione possibile ;)

«Scacco matto.»
«Oh, perdessi meno spesso» sospira Evangeline.
«T’amerei di meno?» Il ragazzo fa per rimettere a posto le pedine, un giocatore accorto, che carezza ogni pezzo levigato con la stessa cura di una sarta che ammira la sua ultima creazione. Un sorriso mesto spunta appena dal suo volto, quindi prende un respiro e continua: «A dodici anni m’innamorai per la prima volta. Una ragazza di strada, capelli rossi, l’accento di Nantes. Una figlia di Satana.»
«Un po’ azzardato, per un bambino.» Lo aiuta nel richiudere la scacchiera in cristallo, dopo che l’esercito è ritornato silenzioso nelle sue bare, custodite da quella lastra lucida, troppo pulita per portarsi dietro così tante vite mangiate. Il re nero giace accanto alla sua regina, ma non si tengono per mano: muto è il ringraziamento verso quella figura femminea che, di nuovo, lo aveva salvato.
«Non ero immaturo» dice, quasi stesse cercando una scusa per il suo comportamento, quindi si alza dalla poltrona rivestita di velluto rosso. Il salone è pervaso dalla solitudine, solo il fuoco nel camino crepita stanco le sue lamentele. Pochi sono i riverberi di luce, qualche candela poggiata su un candelabro dorato, sparse per l’ampia stanza con la casualità di un cameriere distratto.
Tutto giace nell’immobile penombra di una scena da consumarsi al buio.
«Non lo sei mai stato, vero? Non hai età, non hai mai avuto anno in cui annotare un cambiamento nel tuo spirito.» Evangeline resta seduta, e osserva l’uomo percorrere il tavolino rotondo di legno, lentamente, un passo per volta, accompagnando il tutto con una mano che soprappensiero ne ripercorre il bordo incavato. Un dito che segue il percorso del destino, lasciandosi trasportare, senza rivolte.
«Ho cristallizzato la mia vita nel momento in cui mio padre è morto. L’ho visto cadere come un bicchiere di vetro. L’ubriaco tira un po’ la tovaglia, e il calice s’infrange al suolo. Sparge un veleno d’imbrogli.» Lo sguardo, invisibile, coperto da ombre fragili e impalpabili come nebbia, è privato anche del suo consueto chiarore. Il ricordo si disperde, è il liquido che macchia il tappeto una volta che il bicchiere ha completato la sua caduta. « Lei, la rossa… quella bambinetta dei miei sogni, colpa sua» e l’incertezza si diverte a colpire la sua voce in balbuzie stolida. «Mia madre mi aveva… avvisato, e così aveva fatto con lui. Chi ha i capelli di fuoco è solo un bugiardo partorito dall’inferno.» Una pausa: la voce roca sfuma nel soffio di una vita devastata. «Io ho aperto le porte dell’oltretomba, portandola in casa. Era un angelo sperduto fra la polvere di Vaucluse, ma poi s’è rivelato demone dell’anima mia.»
«Continua, per favore.»
«Fuggimmo, incontro alle lavande in sboccio. Vaucluse non è mai stata rifugio più casto: eravamo aliti dispersi nel vento, non eravamo nulla, eravamo la proiezione di un passato cancellato male. Io e la rossa, che ci confondevamo fra i fiori, amandoci fino allo scandalo, fino al disastro, il sangue che riverse la mia vita. Colpa sua, maledetta!» È arrivato alle spalle della donna, ma non la tocca. Osserva la dolce linea della sua nuca piegata in basso, i capelli castani raccolti in uno chignon semplice, gli occhi socchiusi in un ascolto assorto. Osserva le sue bugie, i suoi segreti taciuti, scivolare a terra e liberarsi della loro coltre di gelo.
«Lei… è ancora viva?» chiede.
«Oh, Eva, non sai che il demonio non muore?»
 I Can Wait Forever, Interludio II
I Can Wait Forever, Interludio II

La porta è socchiusa. Non cigola, non produce rumore, quando una mano la spinge per entrare nella stanza. La figura viene investita dai raggi brucianti di un ultimo sole, che alla fine del suo percorso riesce a infuocare l’ambiente, intrufolando tiepidi serpenti di rubino da ogni interstizio.
Un odore di vernici la investe. Casa. Casa è dove c’è lui: dove ogni filo dei suoi capelli di grano si trascina il sapore dell’estate, dove la vita si consuma nei baci riversi sulla sua pelle luminosa.
Sta dipingendo. La sua mano, decisa nell’impugnare una penna, ora è insicura sulla tela e pare giocare con i peli del pennello che tratteggiano delicati il suo dolore.
Gli si avvicina, nonostante vorrebbe in cuor suo restare un’eternità a rimirarlo nell’ombra, sentendolo ignaro della sua presenza. Lascia scorrere le dita sul suo braccio – il primo tocco è un tuono che percuote le membra –, la camicia bianca arrotolata fino al gomito, quindi gliele avvolge attorno al polso con cui acquerella il quadro. Lo guida in alcune rifiniture, qualche istante per assaporare in pace il suo profumo di fiori di pesco, e cannella, e legno di sandalo. Un’armonia di sensi che le inebria la mente.
Ferma il tratto, ed entrambi tremano, hanno sempre tremato, delle foglie nate sullo stesso ramo di betulla e pronte a cadere sulle sponde del fiume. In silenzio. I loro sguardi non si cercano perché non ancora pronti a incontrarsi, rifuggono adocchiando il nulla.
È seduto su uno sgabello senza spalliera, e lei sente la sua schiena che le sfiora il grembo. Stavolta non è il corpetto azzurro troppo stretto a levarle il respiro, è una presa diversa a scuoterle l’animo. Quasi non si accorge di essersi chinata appena, per lasciar scivolare le labbra sul suo collo liscio, le spighe di grano della sua chioma che la sfiorano e le solleticano il viso, come una carezza data in un campo pronto al raccolto.
«Byron, mio Byron». È un sussurro che infrange ogni specchio.
 I Can Wait Forever 9
I Can Wait Forever 9

02/03/1823
Le Havre si è rivestita, con l’arrivo della tua lettera, di una calma surreale… pare aver trattenuto il fiato assieme a me, mentre leggevo. Mi avevi già preannunciato, giorni addietro, della grave fine cui andavi incontro, ma sentirne il dolore, palpabile, il tuo forse stupore a dover accettare il tutto… mi spiace.
Le vite volano via come un soffio, ognuno, in un modo o nell’altro, dovrà passare il periodo dell’ammissione di una perdita. L’arte di perdere non è difficile da imparare, diceva qualcuno. Anche se alla fine si tratta solo di relegare la sofferenza in una parte del cuore, farla giacere e maturare finché essa non deciderà da sola di raggiungere scogli più quieti, privata della forza della mareggiata, e divenire, ormai, un palpitare sordo, l’ombra triste di un ricordo lontano.
Vorrei essere lì con te, in questo momento, consolarti, per quanto le mie fragili membra possano riuscire a farlo. Non sono mai stata brava con le parole, ho comunicato, lungo la mia vita, solo per immagini: il narratore di ogni nostra ballata sei sempre stato tu, con le tue dita lunghe e sottili, da pianista, ogni storia un tasto – nero, bianco, nero, bianco, bianco… un tasto nero è la dolente visione di ogni racconto che non raggiunge il lieto fine. Non ti sembra ridicolo? Piccolo, relegato nell’alto, più duro a premersi, ma così struggente! Lucidato, si riflette dei lucori altrui, per nascondere sulla sua superficie solo gorghi oscuri in cui smarrirsi per sempre.
Ed è per questo che ritengo opportuno venire da te. A salvarti, finché può la mia sola presenza eluderti dal commettere sciocchezze. Non che non confidi nel tuo buon senso, o altro. Oh, non ho più voce per spiegarmi meglio. Desidero solo stare al tuo fianco, rassicurarti, stringerti la mano e con un bacio asciugarti una lacrima fuggitiva che s’allontana dai tuoi occhi tristi. Perdonami se non potrò essere in grado di fare altro, ma quel poco permettimi di donartelo.
Le giornate nella tua villa a Le Havre trascorrono lente. Tua zia è stata molto gentile con me, ad accogliermi come ha sempre fatto, nonostante stavolta tu non eri con me. Ha preso la notizia con garbata mestizia, ma nella notte l’ho sentita abbandonarsi a un breve pianto, nella sua stanza affianco alla mia.
È una donna forte. La mattina dopo, nella sua crocchia argentea, era di nuovo perfetta come lo è sempre stata. Solo due cambiamenti ne incutevano le sembianze: la veste nera, a collo alto, e una luce un po’ più spenta negli occhi.
Io ho trascorso oziosi pomeriggi di lettura. Non mi riesce facile abbandonarmi all’arte, quando ogni pennellata s’inasprisce di rimembranze infelici. Solo una storia può portare, in questo momento, la mia mente altrove: non immagini quanti mari ho navigato, quanti posti ho visitato, nella notte, all’alba, fra le coltri di un cielo cosparso da costellazioni diverse, più nuove, più vive! Ho letto con attenzione trasognata di amori così simili al nostro, ma che mai si sono rivelati più intensi del sentimento che custodisco in me.
Ieri, per festeggiare il sopraggiungere di Marzo – sai bene quanto ami questo mese, quanto gioisca delle ultime, sparute nevicate che ogni tanto mi fanno visita a sorpresa – mi sono addentrata nel giardino della villa, lasciando indietro il patio da cui sovente avevo già assaporato l’aria marina di Le Havre. Il sale pare corrodere qui, prima che negli altri luoghi, la neve che in Febbraio vi si era posata. Ho scovato, nei rami di un biancospino, spuntato come un fiore, un mucchietto residuo di neve. L’ho sfiorato, incauta, graffiandomi la mano e permettendo che i guanti in pizzo venissero pizzicati dalle fronde, ho goduto del suo tocco gelido e dell’incavo sciolto che il mio dito ha formato nel grumo. Per un istante mi sono sentita una bambina. Quante volte mi hai chiamato così, lambendo parti del mio animo che a me stessa erano ancora sconosciuti.
Passeggiare in solitudine, scortata dalle meraviglie della natura fino al pergolato d’ipomee che tanto amo, è stato piacevole e ritemprante. Forse l’ispirazione di un nuovo quadro, qualcosa, stavolta, di davvero sensazionale, si sta affacciando alle finestre della mia mente occlusa dalla nostalgia. Potrei provare a darvi una prima bozza a Londra, che ne pensi?
Ah! Dimenticavo di comunicartelo. È passato di qui tuo cugino per visitare la madre, durante un pomeriggio. L’ho trovato in ottima forma, fresco come un frutto estivo, e sono contenta che la moglie stia conducendo una vita felice. Mi ha chiesto, impudente, quand’è che anche noi decideremo di condurre in matrimonio la nostra relazione. Ho sviato la domanda con una risata lieve, dopodiché mi ha sfidato a scacchi per trascorrere il tempo, accorgendosi forse della sua sfrontatezza e ritornando sui suoi passi. Ha imparato bene dai tuoi insegnamenti, dalle diverse partite che abbiamo fatto non sono riuscita una volta a batterlo.
Sapendo della tua passata sosta, però, si è infervorato non poco. Credo siano due anni che non vi incrociate, dopo un’infanzia intera trascorsa fra le pareti di un’unica dimora, e tu hai eluso una delle possibilità che avevi anche solo per stringergli la mano, come si fa fra vecchi amici. Ha promesso che al tuo ritorno verrà di nuovo.
Ho l’impressione che non siano in pochi coloro che ti danno la caccia.
Post scriptum: nonostante tutto, la domanda del tuo parente mi ha scosso. Quando, per una buona volta, mi sposerai? Non ce la faccio più a far tacere i timori del cuore e le dicerie della gente.
Tua, per sempre,
Evangeline Leibniz
 I Can Wait Forever 7
I Can Wait Forever 7
Ormai lo sapete. I miei episodi vengono pubblicati sul mio blog, gli altri su quello di Vincenzo. Per leggere tutto, andate qui o qui.
Vi avviso che per questioni di cambi di trama e problemi di coincidenze, siamo stati costretti ad apportare lievi modifiche alle date e a qualche particolare delle lettere. Niente di che, se avete letto tutto finora non c’è bisogno che rileggiate il tutto ;)

21/02/1823 – Quarta lettera al mio amato
Ho deciso che resterò a Le Havre. Oh, non mi sfuggirai, stanne certo. Il tuo viaggio si è rivelato più breve del previsto, e io troppo lenta nel mio folle amore a rincorrerti, che già m’eri scivolato fra le dita. Sei come un nastro rosso, un legame che mi stringe il polso e che poi, per disattenzione o per un evento increscioso, si slega e vola al suolo. La tua stretta è sempre stata delicata, quasi impercettibile, ma nonostante tutto mi riscaldava. E ora, più che mai, è davvero questo calore che mi manca: sono fredda come una rosa abbandonata al gelo del più niveo degli inverni.
L’attesa… questa attesa, impagabile, per raggiungerti ancora, si sta scoprendo un periodo raro. Ho sempre avuto un temperamento agitato, tu stesso hai potuto… constatarlo, leggendo la mia ira repentina della scorsa lettera. Ma adesso ho tempo, finché la tua nave non salpi nuovamente alla volta del porto sicuro di Le Havre e delle mie braccia, per riflettere e far ragione dei miei sentimenti.
T’amo ancora, come quel primo giorno. Sotto il mio tocco, il mio sguardo desideroso, ti ho osservato mutare nella candida immagine di un quadro perfetto. È del mio amore che, prima di tutto, sono sicura.
Forse sto cominciando a perdonarti… oh, tutto, tutto questo, pur di averti di nuovo con me. Il fato s’è rivoltato contro i nostri cuori, un nodo nel filo scarlatto che ci lega, e che non vuole permetterci di toccarci ancora.
Ti aspetto. Interrompo qui il mio inseguimento, fino a che la mia anima riuscirà a resistere a questa distanza sgradevole e amara. Può darsi che più in là parta davvero, se solo potessi avere notizie tue e della tua povera madre… spero che questa situazione non si prolunghi più del dovuto. Il piacere dell’attesa che sto riscoprendo mi fa notare che, sai bene, si brucerà presto. È un piacere ingannevole che copre un bisogno ancor più impellente - parlo dei bisogni del cuore, quelli a cui non puoi mancare.
Non permettere che questa miccia arrivi alla sua fine, finirei per scoppiare.
 I Can Wait Forever 5
I Can Wait Forever 5
P.S.: sarà il 2011 un anno produttivo? Non ho mai postato così tanta roba in così poco tempo.

12/02/1823 – Terza lettera
Finalmente sono tornata. Stanca, ch’era sera, o forse già notte inoltrata.
Sono tornata, bramando ogni volta il sapore fruttato della tua pelle, desiderandolo sempre di più ad ogni passo, ad ogni singolo sospiro di giglio, che mi avvicinava a quel quartiere parigino che tanto conosco, e che tanto mi è caro.
Ero lì, a strapparmi lo strascico della gonna da viaggio, tanto i miei piedi calpestavano veloci e agitati le pietre della strada, e i tacchi che vi s’impigliavano senza possibilità di scampo. Tanto correvo, per raggiungere il tuo portone in legno chiaro, e per sommergerlo, il sorriso al volto, di piccoli pugni di gioia. Aspettando che tu, dai piani alti, dal tuo studio – oh, riuscivo anche a vederlo! La luce giallognola delle candele che traspariva dall’ombra delle tende alla finestra, e un’ombra più scura, il tuo corpo chinato a scrivere – arrivassi trafelato a darmi quell’abbraccio di ben ritrovata.
Non che sia indifferente al fragile corpo della tua adorata madre.
Ma davvero il mio cuore ha urtato i cancelli della desolazione, schiacciato come un prigioniero in una gabbia per canarini, quando ha realizzato la tua spiacevole assenza.
Colonia è lontana da Parigi. Era un breve viaggio, solo le vacanze natalizie, niente più, per riappacificarmi con quei parenti lontani che da tanto non vedevo. Colonia è lontana, anche Londra… una manciata di giorni! Non ti avrei chiesto altro.
Dannazione al dì in cui il mio sguardo s’incatenò ai tuoi occhi di mandorla e cannella dispersa. M’hai frantumato l’anima!
Ora basta divagazioni, ecco com’è andata: ho trovato il tuo maggiordomo, solo, nella cucina, e mi ha consegnato la tua lettera. Non ha pronunciato parola, né un tocco di conforto, nulla, mentre mi scorgeva davvero sfiorire come una rosa arsa dal sole. Perché ribollivo di disperazione e dolore, ma anche – e soprattutto – di rabbia. Sì, sono irata con te!
Le tue promesse, vanificate in un soffio. Saremmo potuti partire assieme, affiancati nella stessa carrozza, soggiornare a Le Havre, là dove io ben ricordo che… no, non voglio ricordare ciò che ivi accadde. Ora, mi pare una romanticheria alle soglie del sogno, distante secoli o ere, lontana universi. E pensare che invece è stato solo quest’estate… tutto era cosparso dal profumo dei gelsomini in fiore.
Leggendo al flebile lume che il tuo maggiordomo mi offriva, ho lasciato cadere la valigia sottile che sempre porto con me. Era pronta per irrorare, una volta per tutte, il foglio candido delle tinte del tuo splendido corpo inondato d’amore. Quante mattine mi sono svegliata al tuo fianco, desiderando d’imprimerti così, nel tenue sonno fanciullesco e fra le lenzuola che a stento nascondevano le tue forme. Il mio corredo da disegno, precipitato al suolo! Un gesto così sconsiderato, ma così naturale… tremavo, lo ammetto, e non ho saputo più controllare altro che non fosse il battere delle mie ciglia per scacciare le lacrime. I miei pastelli, riversi a terra, sembravano da soli formare le tinte per un quadro di angosciosa bellezza, alcuni incrinati per la caduta, altri ancora mezzi infilati nella custodia del piccolo bagaglio. Hai distrutto un brandello della mia arte.
Sai bene che le mie mostre, e i tuoi astrusi viaggi da scrittore, finiscono sempre per dividerci. I momenti passati assieme sono una perla di mare che resta perennemente nascosta nel suo ruvido guscio, per proteggerla, per renderla più intima e preziosa di quanto già essa sia. Non puoi vendere la nostra ultima perla così. All’aria, all’asta, lanciala giocoliere, più in alto, cosicché tutti gli interessati possano vederne i riflessi luccicare alla luce. Via, via, chi è il compratore migliore? Tu, vigliacco, che giaci nell’ultima fila, e offri il tempo per comprarla, offri un affetto insulso per una madre che non vedi da anni.
Non sprecherò altre parole.
T’inseguo.
In capo al mondo.
 I Can Wait Forever 3
I Can Wait Forever 3

27/01/1823 – Seconda lettera al mio amato
Caro. Sto partendo… sto tornando.
Il paesaggio che mi dice addio è di una struggente bellezza. La neve, nella notte buia, ha tinteggiato i prati sporchi del suo velo adamantino. L’aria è frizzante, pizzica appena il naso, e ne sento la frescura sotto le mie dita, infagottate in umidi guanti di raso. Vorrei carezzare queste dolci colline, ma è tardi… era tardi, quando vi ho dovuto dare l’ultimo saluto. E tuttora rimpiango di non essermi svegliata, nottetempo, per meravigliare per l’estrema volta la mia mente, con il lento discendere dei fiocchi e il loro danzare fra i bagliori di luna. Un giorno ti porterò con me, un giorno, fra questi boschi incantevoli, giocheremo a rincorrerci. Mi sbroglierai le gonne dai rami, quand’esse vi s’impiglieranno, birichine come i miei pensieri?
Una cameriera stamane è arrivata trafelata che già, triste, avevo posato il primo piede sul predellino della carrozza. Mi ha consegnato la tua lettera. Non posso non immaginare cos’avrei perduto e lasciato indietro, se non avessi indugiato quell’attimo in più a rimirare ciò che ero prossima ad abbandonare. Avrei dimenticato anche una parte preziosa del mio amato cuore!
Ora ti scrivo che i cavalli si muovono ad un allegro trotto, e se porto lo sguardo oltre la finestrella posso ammirare le campagne scorrere mute e solitarie al lato della strada. Che sciocchezza che sto facendo! Ho appoggiato una delle valigie in grembo e ivi, in fretta, vi ho aperto il calamaio e la penna, la pergamena stesa… non oso pensare a come s’imbratterebbe il mio vestito, se un incauto dosso scaraventasse tutto all’aria! Ma questo e altro, tutto, tutto per la gioia e la prontezza che mi porta a scriverti ancora.
Non so quanto durerà il viaggio. Forse rimarrò giorni senza la possibilità di comunicare con te: quest’amara riflessione mi strugge, il pennino tentenna al tremore della mia mano. Mi sento indifesa, senza le tue braccia a cingermi… e a sussurrarmi poesie.
Le tue poesie… sei l’unico che in una manciata di parole sa infiammarmi le membra, spezzettarmi l’anima, e poi raccogliere il tutto per creare una composizione solo tua: la mia vita rimodellata, una statua dagli occhi socchiusi in estasi.
Post scriptum: nel viaggio di ritorno mi fermerò alcuni giorni – meno di una settimana, in ogni caso – nella dimora di Madame Leroy, una mia vecchia conoscenza, per riprendere le forze. Il viaggio è lungo, e non me la sento di affrontarlo tutto d’un fiato: lei abita a Namur, quindi lungo la strada, ed è tanto che mi prega di farle visita. Spero che questo ulteriore ritardo non ti faccia spiacere.
 I Can Wait Forever
I Can Wait Forever
Un piccolo pensiero, una lettera che, in fin dei conti, parla molto di me. E quella nella foto qui sotto sono io, in effetti, mentre scrivo ^^
23/12/1822 – Lettera al mio amato
Oggi, in qualche parte del mondo, è il compleanno di qualcuno. Forse il tuo.
Scrivo su un tavolo minuto che non mi è mai appartenuto, e che per caso s’è trovato in questa stanza dove sommariamente soggiorno. Il letto è a due posti, ed è strano addormentarsi da sola in questo vasto spazio, con coperte calde e morbidi cuscini che nella notte prendono forme umane, ma non mi abbracciano. O, almeno, non lo fanno come lo facevi tu.
Al nostro addio, ci siamo detti che nessuna distanza avrebbe potuto dividere i nostri cuori. L’uno nell’altro, mano nella mano, sangue che scorre in due vene di due corpi diversi, ma che – disgrazia! – è lo stesso, condiviso come una caramella fra due bambini. Ogni goccia mia ha sapore di te.
Oggi mi sono tagliata. Un piccolo graffio sull’indice, sottile. Colpa del gatto. Ed è sgorgato un po’ di sangue, sai? Ma non sapeva di te. Era aspro, acido, era solo mio, era qualcosa d’estraneo a ciò che ero abituata a condividere.
Posso aspettare. Posso aspettare di sentire di nuovo quella dolcezza scivolare fra il liquido rosso, e avvolgermi del suo incantevole odore. Ma intanto… ogni giorno senza di te – senza te con me – è come un coltello che va a recidere sempre la stessa ferita, e apre cascate acidule da cui non vorrei mai attingere vita.
La sedia da dove ora ti scrivo è un semplice sgabello in legno, la parte superiore rivestita di un cuscino duro e ruvido al tatto, color panna. Odio quel giallognolo che mischiano dappertutto, è un colore così obsoleto! Rivoglio la mia stanza acquamarina, quella che condividevo con te. E rivoglio quello specchio sottile in cui apparivo così fantastica, come lo eri tu quando mi sedevi al fianco e mi carezzavi la schiena, dolcemente, un ricordo cui per ora non desidero rimembrare. Altrimenti finirei per disperarmi ancora.
 Qua lo specchio è un enorme lastrone posto in fronte alla scrivania, e ogni volta che alzo lo sguardo dalla pergamena vedo il mio volto deturpato dalla solitudine. Le guance incavate sotto il naso, che seguono lunghe curve fino ai bordi delle labbra, perennemente rivolti al basso. Gli zigomi sembrano ancora più appuntiti di come lo sono di solito, e il viso è gonfio, gonfio di dolore e della cioccolata che mangio. Divoro tutto, perché ho paura che la mia bocca, nell’astiosa brama di muoversi, cerchi altre lingue cui concatenarsi. Che pensiero stupido. Sono solo golosa. Golosa di qualcosa che s’avvicini al sapore del tuo collo, delle tue labbra, del tuo corpo…
Qua lo specchio è un enorme lastrone posto in fronte alla scrivania, e ogni volta che alzo lo sguardo dalla pergamena vedo il mio volto deturpato dalla solitudine. Le guance incavate sotto il naso, che seguono lunghe curve fino ai bordi delle labbra, perennemente rivolti al basso. Gli zigomi sembrano ancora più appuntiti di come lo sono di solito, e il viso è gonfio, gonfio di dolore e della cioccolata che mangio. Divoro tutto, perché ho paura che la mia bocca, nell’astiosa brama di muoversi, cerchi altre lingue cui concatenarsi. Che pensiero stupido. Sono solo golosa. Golosa di qualcosa che s’avvicini al sapore del tuo collo, delle tue labbra, del tuo corpo…
I miei stessi capelli sono spenti. Vorrei che ci fossi tu a pettinarmeli; perché, ricordi? Ti dicevo che erano troppo lunghi, ma tu non volevi che li tagliassi, e allora mi venivi alle spalle, mi toglievi delicatamente la spazzola dalle mani e prendevi a lisciarmeli fino in fondo alla schiena. Eri così leggero che quasi non sentivo il tuo tocco, e i nodi restavano lì dov’erano perché temevi di farmi male, eseguendo più pressione del dovuto. Nodi che creavano un groviglio imbarazzante, invero, però quanto mi mancano, ora!
Posso aspettare a lungo, forse per sempre… e chiedermi quanto durerà questo maledetto viaggio lontano da te. Non ho nemmeno un ritratto che riassuma i tratti del tuo volto. Non ho avuto il tempo di fartelo. Deplorevole, non credi? È che ho paura di uccidere la tua bellezza, se solo cercassi di riprodurla con le mie mani grossolane, poco gentili. Tuttora ho paura, di cosa non so.
Mi sento come una margherita: m’ama, m’amerà ancora, davvero m’ama ancora? E intanto sfiorisco. Deliziosa, mi ritroverai che sarò solo un gambo! Un tuo bacio, solo uno, e sboccerò di nuovo. È una promessa.
 Il Cacciatore di Bolle
Il Cacciatore di Bolle
Per Clarissa.
Una scia di bolle si riversa nell’acqua, due, tre, quattromila lucide sfere che scompaiono e ricompaiono fra i flutti, e che inneggiano battaglia con la spuma biancastra loro compagna. Le si può vedere, dietro la barca, che continuano a rendere il mare uno smeraldo rilucente, bolle che sono i picchi brillanti delle sue oscure sfaccettature. Man mano che l’imbarcazione s’allontana con il lento rollare dei remi, anche loro spariscono alla vista, eppure, là, all’orizzonte dove la spiaggia diventa sempre più una striscia d’ignoto, uno sfavillare improvviso fa pensare che ce ne siano ancora. Per quanto tu le possa scacciare, per quanto questa scia possa perdersi fra le sue acque salmastre, un gruppo di bolle spavalde segnerà il cammino. E ne porterà il ricordo, come ogni bolla è un sogno che, al suo scoppiare, s’interrompe e si acquieta fra le lande del suo onirico mondo.
Seguendo il flusso al suo nascere, laddove i due filamenti schiumati d’iride s’incontrano in un solo punto, sulla chiatta si scorge un giovane uomo. Il sole di mezzogiorno batte sui suoi capelli indorati, tanto da rischiararli ancora e bruciarli nel caldo tempestivo di una primavera precoce.
I suoi occhi nocciola sono posati sul nulla, semichiusi, piccole gocce di sudore a truccarne le ciglia folte e a inasprirne la fronte liscia. Il ritmato remare pare non voler finire, un avanti e indietro delle solide braccia che non produce effetti, non ora che la visuale della terra è stata inghiottita, lontano, fra i rigurgiti delle onde, e l’instabile base su cui poggia la barca è una coperta fluttuante.
Lo sguardo del ragazzo pare essere concentrato su un particolare che sfugge, qualcosa di incommensurabilmente distante, come solo il sospiro di un pensiero può essere. Intanto che il tempo scorre, una lumaca di mare nell’impotente scenario d’un acquario domestico, la fotografia di questo singolare mondo assume i contorni della stanchezza, della noia. E della voglia di sapere, e scoprire, cosa nascondono l’acqua e le tenere bolle che ne pervadono la superficie.
L’uomo deve aver raggiunto il suo obiettivo, perché abbandona i remi di legno nelle incavature apposite, le punte che ancora sfiorano il pelo del mare in un solletico affettato, l’ombra delle loro forme affusolate che crea due chiazze più scure ai fianchi della chiatta. Quest’ultima è piuttosto piccola, tanto da sembrare una scialuppa di salvataggio di qualche veliero pirata, le stesse lastre lignee appaiono scheggiate in più punti e corrose dal sale, le cicatrici di numerosi, incantevoli viaggi. Nonostante tutto, la forma allungata della barca ne favorisce l’andamento veloce e la stabilità, come se inconsciamente non vedesse l’ora di frangersi sulle rive di nuove conquiste.
Un mormorio s’ode a interrompere la quiete. Lo sciabordare, sottofondo gradevole, ormai scompare, le orecchie acuite a cercare questo suono inquieto e a non perdersene una nota; come un gabbiano affamato, l’udito rapisce la melodia dalle fameliche braccia dell’abisso e ne trangugia ogni impercettibile squama.
«M’avevi chiamata, Cacciatore?»
Ed eccola là, regina del regno, una sirena s’è sporta dalle profondità sue dimore. Poggia le braccia sul bordo della barca, nella metà precisa della sua lunghezza, dove il giovane per qualche istante l’aveva attesa, seduto. Un appuntamento galante si dipana fra le brame del cielo, complice la meriggiata odorosa di saline e di pesci quasi come i pantaloni blu stinto di un pescatore, e avvolge piacevole i due.
La sirena ha una coda lunga che si disperde e sfuma le sue tonalità nell’acqua che le lambisce i fianchi in una carezza effimera e suadente. Ma lo stesso le sue scaglie, finché è possibile scorgerle, attirano per la loro inconsueta lucentezza: un acquamarina misterioso, ma non solo quello, il verde delle alghe e il colore innaturale di un pesce luna, l’effimera sfumatura di un frantume d’ametista, ogni singolo brandello di pelle che racchiude un segreto proveniente dal mare.
E lei li protegge, laggiù, tutti, come timidamente i capelli bagnati le proteggono i seni nudi, ricoprendoli dei loro boccoli castani.
«Mia dolce». Lui che si sporge, seduto su una delle panche malandate del suo tristo vascello carico di barattoli. Stipati, di mille e mille dimensioni diverse, sotto ogni banco, nel ripostiglio chiuso a prua, e nell’ammasso informe sull’altra sponda malamente coperto da un velo plastificato marrone, sembrano vuoti, infagottati nel tappo che ne sigilla l’interno. Ricordano i vasetti di marmellata fatta in casa, le etichette collose slavate dai numerosi lavaggi che assieme alla confettura li rende appiccicosi e sgradevoli al tatto. Alcune contengono qualcosa, oppure è solo un raggio solare più audace degli altri che le cosparge di una polvere d’arcobaleno e lascia intendere, appena, una bolla incatenata all’interno delle ampolle dell’alchimista distratto.
«Cosa vuoi, ancora?» gli occhi di lei, cosparsi dai brillanti di una mestizia sopita, s’inaspriscono con il tono di voce. Mia dolce! Se è così amabile la memoria che porti di me, amami davvero come il mio cuore vorrebbe.
«Dammi un tuo sogno» le si avvicina, fin troppo, tanto che il suo naso tocca quello della sirena, umido d’acqua e pallido, liscio come un frammento di rosa. Vuole, desidera quello che chiede, e la richiesta è quanto mai più simile a un ordine.
«Dammi un tuo bacio» l’eco della sua voce femminile e famelica, un incanto cui nessuno di solito sa resistere. Nessuno tranne il Cacciatore di bolle, che resta impassibile, o forse solo irritato.
E, infatti, egli si discosta, nonostante sia pronto a donarle ogni effusione lei gli chieda, pur di possedere un suo sogno. Ogni Cacciatore sa che non c’è niente di più prezioso della bolla di un respiro di sirena… «Respira, mia dolce, sotto quel velo d’acqua che t’ha fatto nascere». Ora il suo tono di voce è più sereno, ma quasi disperato nella pretesa.
«Ah! Vorrei non averti ascoltato, quando mi abbracciasti quella prima notte di tanti anni fa. Non ho più sogni di cui privarmi». Distoglie lo sguardo, posandolo fra i flutti dove la sua coda teneramente sbatte per mantenerla in superficie. Il suo muoversi per un momento si quieta, quasi voglia lasciarsi annegare dalle onde e interrompere ogni discorso. Tutti i sogni, se non uno… che quella notte, quando cominciai ad amarti, e m’amasti anche tu, continuasse per sempre.
«So che, invece, ne hai ancora». Una certezza, come il sorriso vispo che per un istante gli avvolge il viso. Ogni Cacciatore sa quanti sogni esistono al mondo, ogni bolla è un sogno da catturare: conservarlo, e tenerlo al sicuro, non farlo scoppiare. «I tuoi sogni diventano eterni, se solo li dai a me,» una pausa, e poi, perentorio: «dammene un altro».
«E tu, come li hai custoditi! Mi privi della possibilità di renderli vivi, non è questa una sofferenza di per sé atroce?» e infine la volontà ha il sopravvento, e davvero, in un battito di ciglia, la sirena scompare, solo un velo d’acqua increspato e una spruzzata di gocce a segnarne la partenza. Più giù, l’ultimo bagliore delle sue squame risponde all’arrivederci del lucore del sole. E il sogno di quest’amore, non lo darò mai a nessuno. Poiché, già adesso, è solo puro dolore.

Una lacrima nel mare riesce solo a renderlo più salato, e un pianto porta con sé il silenzio delle stelle che si gettano nel loro riflesso sull’acqua, fiocamente, un riverbero lontano. Di fronte alla distesa che balugina appena, un altro rischiararsi più recente sfoggia gocce di luce nella notte. Dagli edifici si scorgono le ombre del movimento all’interno delle finestre, varchi illuminati da lampade dal caldo colore giallino, e i lampioni delle strade punteggiano percorsi sconosciuti.
Un sentiero si fa largo fra esso, buio, oscuro, la via per la solitudine: s’avvinghia ai viandanti sperduti, agli innamorati non corrisposti, alle madri in pena per qualcosa che non sanno descrivere, un presentimento, la nostalgia, un rimpianto nascosto.
Il porto è incavato in una baia naturale, al di là di un promontorio su cui s’inerpica la cittadella. Poi, spiagge che degradano gradualmente nella riva, e lidi già chiusi, e nessuno di cui si scorgano le orme sulla sabbia battuta.
«Perché piangi?» una voce soave, attutita dal traffico della parte abitata e dal lungomare in fermento. Diversi metri però dividono la confusione della gente dal tetro rifugio nei pressi della risacca.
Il ragazzo, seduto sulla rena, alza gli occhi offuscati e cerca invano di ghermire nell’aria un volto, un ritratto, a cui accompagnare quelle parole. Ma il suo intuito è schiacciato dal peso della solitudine che, tempo prima, l’aveva ricondotto sul suo sentiero di sangue. Abbandona la ricerca, solo risponde: «Perché mi ero perso, e ora la mia vita m’ha ritrovato».
«Non puoi smarrirti di nuovo, se questo è capace di renderti felice?» chiede ancora. Il giovane s’accorge che il timbro è vagamente femminile, e si trascina dietro un’eco affabile come il frusciare delle onde.
«Non so il modo» tace per un istante, le labbra semischiuse per lasciarvisi insinuare un pensiero, una commiserata consapevolezza prima perduta, «non so più il modo». Ha una mano poggiata sulla fronte, a reggere una frangia sbarazzina del color dell’oro.
«Comunque, hai perduto questo». Si sente il rumore di qualcosa di metallico sbattuto in terra, il clangore smorzato dagli sbuffi dei granelli di sabbia che si dividono per raccogliere in una conca l’oggetto. La voce continua, un’altra domanda: «Cos’è?»
Lui prende il manufatto e se lo rigira fra le mani, un sorriso lieve che gli increspa le labbra. Fra i palmi sente un manico lungo e legnoso, e alla punta quella rete dalle trame vicine, una pellicola viscosa e lievemente appiccicosa come la tela di un ragno, tesa a unire gli spazi fra i filamenti. Sotto i piedi nudi, avverte d’improvviso l’acqua fresca della sera lambirgli le dita. Quando si era seduto, era ancora il tramonto, e la marea non era così alta. «È il mio retino acchiappa-bolle». L’altra gli risponde con una risata cristallina, e il lieve battere di qualcosa… gli ricorda la coda di un pesce che s’agita sul bancone di un pescatore. «Cosa ci trovi di tanto ridicolo?». Fa lui, sprezzante.
«Niente», dice la donna, ma il richiamo del suo riso le rende le parole tremule e acute. «Dimmi, Cacciatore, cosa ci trovi tu di tanto bello nell’acchiappar bolle?».
Il ragazzo sussulta sentendo una mano bagnata agguantargli il braccio sinistro in una stretta delicata. Volta il viso in quella direzione, e i suoi occhi incontrano quelli di una giovane che gli sta sorridendo. Nella luce delle stelle, vede un bagliore tentennare sulle sue pupille, ma i colori sono sfocati, persi in un gioco di flebili chiaroscuri e blu intensi. Si lascia catturare da quello sguardo marino, e comincia a parlare: «Trovo sogni. Li conservo» si ferma, come cercando di trovare una via semplice per racchiudere il tutto, e scacciare la confusione dal volto di lei. Le loro mani ora sono intrecciate, e il suo profumo salato gli inebria la mente.
«Sono… un Cacciatore di bolle. Ogni bolla è un sogno, e quando essa scoppia anche il sogno scompare, forse per una dormita interrotta, lo svegliarsi da un incubo, la fermata del treno tanto atteso che di colpo arriva troppo presto. Una sveglia che ti scuote di prima mattina» viene impadronito da un tentennamento breve quanto un respiro preso, profondo, a incanalare nei polmoni l’aria fresca della calma serata estiva. «C’è qualcosa di affascinante nel rubare quei sogni prima che scompaiano del tutto.»
«Cacciatore! Ladro, invero. Che te ne fai, di tutti questi sogni?» la fanciulla è incuriosita, e a ogni verbo pronunciato si fa più vicina, attratta da lui, uno sciabordio sommesso che accompagna ogni sua mossa.
«Li conservo» di nuovo lo stesso termine, per descrivere il suo compito, il suo inafferrabile gioco. «Ho delle ampolle in cui le bolle non potranno mai rompersi. Dovresti vederle, nello scantinato, tutte insieme danno l’impressione di un magazzino angelico. Un tocco di luce e ti trovi sommerso in un arcobaleno abbagliante. I sogni lì saranno eterni, mentre le persone a cui li ho sottratti continueranno a vivere normalmente… senza di essi».
«È crudele» sussurra lei, e il suo respiro arriva a sfiorargli la guancia in un tenero tocco.
«È normale. Non puoi interrompere un sogno. I sogni sono qualcosa di speciale, di fragile. Vanno tenuti al sicuro, lontano da chi non ne comprende la vera importanza, da chi non ne apprezza la frangibile bellezza». Un velo di malinconia si posa sul tono del giovane.
«Parlami delle bolle, invece. Sono solo semplici bolle! Ne esisteranno a miliardi, nel mondo, troppe per essere tutte sogni» l’incredulità di lei è tangibile nell’aria.
Il ragazzo cerca il suo sguardo. «Forse non sogni abbastanza».
«E tu? Hai ancora qualche sogno?».
«Non ne ho mai avuti».

Esistono tanti tipi di bolle, ognuno per una specifica varietà di sogno. Il ribollire dell’acqua in una pentola per cuocere la pasta, le bollicine dello sbrodolare di un bambino o quelle che spuntano su una pozzanghera mentre piove. Il bagnoschiuma in una vasca, il sapone fatto apposta per le bolle. Il respiro di qualcuno sott’acqua.
Il respiro di una sirena. Quanti le ho già rubato? Quanti ne ho mozzati, con i miei baci, e le bolle che mi ha donato?
Il Cacciatore si getta nel mare, dietro alle ultime chiazze di colore che rivelano la presenza di lei. Nuota, per quanto sa, fino in fondo agli abissi, il fiato che gli manca in gola ad ogni apertura delle braccia in più, ad ogni grado di temperatura che s’allontana come la macchia indistinta del sole sopra di loro.
Ricorda il sapore del bacio che quella notte si scambiarono, sotto un cielo privo di luna, e i sogni che cominciò a rubarle da allora, da quando s’accorse di quella sua natura gentile e stupenda. Ricorda il sapore della sua pelle, che in quegli anni non è mai cambiato, fresco come il succo di una noce di cocco, salato e piacevole come un riccio di mare. Prezioso come una rara conchiglia.
Sempre più in basso, a caccia di un sogno. E il paesaggio, quest’acqua inconsuetamente gelida che perfora i pori del viso e pizzica le mani, è davvero da sogno. Si estende, placido, in ogni direzione, e avvolge tenero, una coperta che leva i sensi e intorpidisce le membra, e guida a un sonno vicino.
Le sue braccia lo circondano, anche se non sa da dove è spuntata. Fino a un attimo prima sembrava così distante, sembrava che l’avesse persa, e il Cacciatore non voleva che perdersi con lei. Ma ora la sirena lo sta abbracciando e lo stringe forte, il calore del suo petto che con il contatto si diffonde nel suo corpo infreddolito.
Vede le bolle del respiro della donna creare un vortice attorno al suo volto, mischiarsi con i batuffoli dei capelli castani sparsi tutt’attorno e salire in un vortice verso l’alto. Piccole, incredibilmente pregiate, perle rilucenti dell’ultimo sogno della sirena. E nel loro baluginio d’arcobaleno, scorge uno specchio di loro due, quella notte, e per tutti gli incontri a venire, un diorama di ogni bacio e ogni carezza, e ogni tenero contatto.
Un sogno non eterno, forse il più debole e fragile che avesse mai cercato di racchiudere nelle sue ampolle malandate. Se solo non fosse stato un Cacciatore, se solo avesse potuto averne, è certo che quello sarebbe stato un sogno anche suo. E, quando l’ultimo respiro gli sfugge dalle labbra, negli occhi già socchiusi a lasciarsi smarrire dal sonno, una piccolissima bolla s’innalza danzando a confondersi con quelle di lei.

 The Olde Village Lanterne
The Olde Village Lanterne
Salve lettori! Spero abbiate passato buone feste :)
Io sono andata in Polonia come accade ogni anno a trovare mia nonna e i miei parenti, da qui spiegata la mia lunga e prolungata assenza. A dire il vero, sono tornata solo stasera.
Avevo preparato un post con un racconto natalizio (non poteva mancare!), programmando la pubblicazione per la mattina del 25 Dicembre. Non avevo la connessione internet in Polonia, se non in rari casi in cui davo sparute sbirciatine alla posta elettronica, perciò non potevo controllare se aveva postato tutto regolarmente o meno. Ora torno e vedo che, a quanto pare, qualcosa deve essere andato storto.
Poco male! Anche se il Natale è passato e si riprende la solita routine, confido che voi abbiate quel pizzico di nostalgia necessario per leggere questo racconto pubblicato in ritardo. Perché voi lo volete leggere, non è vero? ^^
Inoltre si tratta della Fan Fiction su Merlin che vi citai qualche post fa, e con cui ho partecipato a un Contest. Sono arrivata quarta classificata (e ne sono pienamente soddisfatta, per il lavoro che ho fatto) e inoltre ho avuto il Premio Originalità, cosa che non mi aspettavo affatto. In effetti quando scrivevo il racconto ho sempre pensato che tutto ciò che mancava fosse proprio l’originalità… in ogni caso ci ho messo davvero tanto impegno, e la trama riempie diverse pagine, quindi è anche una storia un po’ lunga.


La Fan Fiction prende spunto da una canzone dei Blackmore’s Night (il cui video vi posto alla fine del racconto), da cui la storia prende anche il titolo e le cui citazioni si interpongono fra una scena e l’altra. Spero vi piaccia… di mio in queste settimane di isolamento da pc ho scritto un racconto (Clarissa? “Il cacciatore di bolle” è pronto, un’ultima vista e lo vedrai postato, come promesso) e qualche altro appunto, in modo da prepararvi alcuni post interessanti nei prossimi giorni.
Buona lettura!
P.S.: stavolta niente immagini, sono sfinita e il post è già lungo di suo ;)

Flebili fiocchi di neve cadevano su Camelot. Erano piume d’angelo strappate attraverso lampi di magia, e disperse, come grano su un terreno da poco arato, come chicchi gettati da mani di nuvole ed aria. Si riversavano dal cielo di bianco dipinto, trascinate dalle correnti, poggiandosi sul terreno col rumore di un bacio caduto. Una coltre adamantina che si posava dolcemente sull’altura della città e sui terreni vicini, portando con sé un’aria fresca e gioiosa, un’aria di festa. La brezza si spargeva gelida, accogliente fra le gocce gelate di cui la volta celeste la rivestiva, limpida come solo in inverno può accadere. Ogni suono si ripercorreva di mattone in mattone, di pietra in pietra delle costruzioni paesane, cristallino e ridente.
Per la festività, ad ogni capanna era stata appesa una lanterna in ferro battuto, che anche in pieno giorno era accesa della sua accogliente e calda luce. Ogni abitazione aveva il suo piccolo faro d’allegria e speranza, la fiammella che vibrava e danzava, rifuggendo gli spifferi di vento che tentavano di spegnerla attraverso le minute fessure dell’intelaiatura. Ogni tanto si udiva anche lo sferragliare momentaneo del metallo, che sfregava contro il gancio a causa di una raffica più audace delle altre. Da lontano, i lumi parevano spiriti appostati ad indicare il sentiero, seduti fra la paglia di un tetto o su un barile rovesciato, oppure ancora aggrappati a un’asta, i piedi a sfiorare le cataste di legna per i camini.
Nelle strade, i bimbi erano una fiumana che si spandeva, sempre in corsa verso la felicità; talvolta picchiettavano ruote di ferro con un bastone stretto in mano, usando la stessa foga di un fabbro alle prese con un ferro di cavallo e un’incudine. E anche i cerchi volavano come i loro piedi lesti e agili, galoppavano giù per le strade, lasciando un’orma continua e ondulata sulla terra imbiancata da poco.
«Milady, attendete!» una giovane serva rincorreva ridendo una fanciulla. Si muoveva velocemente per le vie della città bassa, superando i bambini e le case, lo sguardo in avanti per non perdere di vista la padrona. Le mani alzavano appena la povera veste per evitare che strusciasse in terra e intralciasse il cammino, il tessuto grinzoso che si ripiegava zuccherato in mille e mille onde giallo oro.
«Gwen, che meraviglia, ha cominciato a nevicare!» la donna fuggente si fermò, voltandosi verso la compagna, il fiato che le si condensava a poco dal viso per il gelo. «Non ricordo quand’è stata l’ultima volta che la neve si è posata su Camelot prima di Yule» aggiunse, e alzò le mani nude al cielo. Fece un giro su se stessa, i batuffoli ghiacciati che la ricoprivano di brillanti colorati d’arcobaleno, e s’intersecavano ai suoi capelli corvini intingendoli di gocce d’inverno. Frammenti rilucenti come diamanti s’incastrarono anche sulla pelliccia bianca di volpe che le proteggeva le esili spalle. «Mio padre diceva che, quando nevica a questa maniera, sono gli angeli del cielo che dall’alto sbattono i loro piumini dopo una notte di sonno».
«Sì, ma così vi sporcherete tutto il vestito, e gli angeli non ve ne regaleranno uno nuovo. Stasera avete la cena con il re, non avete tempo per cambiarvi, e vi devo ancora preparare l’acconciatura» Gwen le arrivò vicino che già la rimproverava dolcemente, il fiato grosso per la corsa e il volto appena aggrottato dall’apprensione, che subito si distese in un sorriso. Morgana era felice, e solo questo, per ora, contava.
La nobile le prese delicatamente le mani, guardandola con fare affettuoso «Non ti struggere. Faremo in tempo, e un po’ di ritardo non farà di certo arrabbiare Uther».
«Certo, è solo la vigilia di Yule. E a Camelot stanno venendo solo i più grandi re e principi di tutti i regni confinanti» mormorò la serva, «e voi mi dite di non preoccuparmi…» ma Morgana era già avanti, a perdersi fra i giochi della prima neve, a carezzare volti di piccoli e a rincorrere il nulla, una musica lontana che si spandeva nell’aria.
“The olde village lanterne
Is calling me onward
Leading wherever I roam
The olde village lanterne
A light in the dark
Bringing me closer to home”
[La vecchia lanterna del villaggio
Mi sta chiamando in avanti
Dominante ovunque io vada
La vecchia lanterna del villaggio
Una luce nel buio
Che mi porta più vicina a casa…]
«… di pace, serenità e,» Uther Pendragon bloccò il suo discorso, sentendo le porte del salone del castello aprirsi con il loro clangore inconfondibile. Ne entrò una guardia che fece pochi passi all’interno e poi si fermò, profondendosi in un inchino.
«Avevo chiesto di non disturbare la cena» disse il re, stizzito, una vena di preoccupazione nella voce al pensiero di cosa avrebbe potuto costringere la sentinella a irrompere nella stanza.
«Mio signore, volevo annunciare l’arrivo di lady Morgana» il soldato tornò indietreggiando al suo posto davanti al portone, che richiuse non appena la ragazza fu entrata. Per un secondo gli sguardi di tutti i convitati furono puntati su di lei, attratti dalla bellezza e dal contegno che sprigionava la sua figura. Un lungo abito violetto ne avvolgeva le forme sinuose, stringendosi sulla vita sottile con una cintura intarsiata d’oro e ametista, la gonna che si apriva in numerosi veli dalle tonalità del mare di notte, dei glicini e delle lavande, delle orchidee e della porpora più scura. I capelli erano stati raccolti dietro il capo con una spilla in modo da lasciarle il volto scoperto, e una poinsettia irradiava le sue tonalità rosse rubino dal lato destro del capo.
L’avevano attesa per lunghi minuti, dopodiché Uther aveva deciso di cominciare anche senza la sua presenza. Già si dubitava della sua partecipazione, e alcuni cortigiani avevano ipotizzato pettegolezzi e dicerie il cui dilagarsi fra gli invitati non s’era fatto attendere. Ma ora era qui, splendida portatrice d’incanto.
«Scusate, padre, scusate tutti voi» pronunciò, il capo chino e le mani giunte in grembo in segno di spiacere.
«Credevo non saresti più venuta» fece notare l’uomo, duramente, quindi le fece cenno di posizionarsi sullo scranno vuoto al suo fianco.
Il salone era un enorme vano diviso in tre navate da colonnati in tufo semplice. Nelle navate laterali, più piccole, erano stati posizionati i servitori di ciascun convitato, che prendevano parte al banchetto stando in piedi o su delle panche addossate alla parete. Al centro, invece, delle lunghe tavolate erano state disposte a ferro di cavallo, con la famiglia reale di Camelot posta sul lato più breve che fronteggiava il portone in ebano.
«Allora, sì» continuò Uther, cercando di riprendere ciò che si era interrotto, «stavo appunto affermando come questa cena abbia l’intento di portare al nostro, e ai regni confinanti, un periodo di pace e serenità. D’altronde Yule è sempre stata definita una festa magica, pagana, e il mio impegno è di debellare non la festività in sé, in quanto radicata nella tradizione del popolo e della stessa corte, ma distruggere la sua celebrazione malsana. È per questo che, per stasera, due turni di guardia si divideranno per tutta la città, imprigionando chiunque venga sorpreso a compiere atti malefici di spudorata magia. Yule deve continuare a vivere come una festa innocua, e non malefica. Perciò buona cena, miei cari, e che la mia lotta al male possa, col vostro consenso, continuare imperterrita e vincente» al concludersi delle parole del re, i commensali brindarono, e in un attimo un centinaio di calici dai riflessi dorati e d’argento si portarono alla bocca di ognuna delle persone presenti in sala. Ogni coppa riluceva dei bagliori inviati dalle numerose lanterne e torce appese a intervalli regolari sulle pareti in pietra del castello, creando un gioco di fasci luminosi che rendeva l’ambiente festoso e piacevole.
Tutti sedettero e, fra risa e chiacchiere scoppiate d’improvviso dopo il silenzio del discorso di Uther, presero a consumare le numerose pietanze portate dalle cucine. Da un angolo cominciò a dipartirsi una musica allegra e gioviale. Alcuni musicisti, fra cui spiccavano un suonatore di ghironda e una giovane che strimpellava una chitarra, avevano attaccato un movimento d’introduzione al banchetto. Una ragazza dai lunghi capelli biondi e mossi avanzò di qualche passo sulla pedana rialzata riservata ai musicanti, e intonò il suo canto ammaliante e delizioso, una voce che avrebbe accompagnato, soave, l’intera cena.
“Some choose to fall behind
Some choose to lead
Some choose a golden path
Laden with greed
But it’s the noble heart
That makes you strong
And in that heart, I'm with you all along...”
[Alcuni scelgono di restare indietro
Alcuni scelgono di guidare
Alcuni scelgono un sentiero d’oro
Gravido d’avidità
Ma è il cuore nobile
Che ti rende forte
E in quel cuore, io sono con te da sempre…]
«Giornata pesante, Uther?».
Nella semioscurità della sua stanza, il re si stava preparando per andare a letto. La stanchezza, dopo la fine dell’estenuante cena, si era riversata sui suoi occhi come un manto, un panno steso sul corpo di un morto: irreversibile, impossibile tentar di riaprire le palpebre che sempre più ardivano a chiudersi e avvolgere tutto nell’ineluttabile oscurità del sonno. Era stata una giornata lunga, sfibrante, e i postumi della fatica avevano investito il re tutti in un momento, quasi a ricordare la sua età avanzata.
Una voce però lo riscosse dai suoi pensieri rivolti alle lenzuola calde, un sussulto che gli percorse le membra. Quel suono era così familiare alle sue orecchie, che gli occhi cercarono subito il viso pallido di una donna, e i suoi capelli raccolti in ciuffi come serpi lacustri emerse da un lago.
«Nimueh» sussurrò l’uomo. La strega era comparsa vicino a una delle colonne del baldacchino, e ne sfiorava la tenda di raso amaranto con la mano sinistra. Le sue labbra contornate di un rosso scuro erano aperte in un sorriso devastatore, le sopracciglia inarcate come quelle di chi sa cosa cerca, cosa vuole.
«In persona» rispose lei, avanzando di poco. Le sue vesti, delicate e dello stesso colore di un acero giapponese, frusciarono appena fra gli sfregiati tagli e strappi nella parte bassa dell’abito.
«Dimmi cosa ci fai qui. Non ho tempo da perdere in chiacchiere» Uther non staccava lo sguardo da quello della donna, la ragione persa fra ricordi tristi, sconvolgenti. Non voleva lasciare che si prendesse gioco di lui, non di nuovo, e intanto rimaneva immobile vicino alla cassapanca su cui aveva appena posato la cintura con la spada. Qualche membro della servitù aveva avuto l’accuratezza di poggiarvi sopra un vaso pieno di ellebori freschi, che spargevano nella camera da letto il loro lieve profumo.
«Ho assistito al tuo piacevolissimo discorso di prima, al banchetto» cominciò con tono neutrale Nimueh, «questa volta hai davvero superato te stesso. Tramutare Yule in una semplice festa per comuni mortali… lodevole».
«Ho fatto ciò che dovevo, sai bene che non tollero la magia, non qui a Camelot».
«Sai che a Yule noi Sacerdotesse della Religione Antica usavamo fare dei doni?» chiese d’un tratto Nimueh.
«No, ne ero all’oscuro» Uther parve per un secondo corrucciato, non riuscendo a capacitarsi di cosa l’altra avesse in mente. La stanza era illuminata solo da qualche raggio di luna che penetrava dall’ampia vetrata posta alle spalle del re, e illuminava di un’ombra tetra la strega. «Ma non vedo come questo possa avere a che fare con il nostro rapporto».
«Uther, sei così solo ormai. Pensavo di farti un dono» così dicendo si spostò verso la finestra a volta, che dava sul cortile interno del castello, «un dono speciale».
«Temo i nemici anche quando portano doni».
«Io ero tua amica».
«Da quando Ygraine è morta, non lo sei più, Nimueh».
Seguì un lungo silenzio, in cui i due si studiarono, fuggendo l’uno lo sguardo dell’altro. Il re attendeva solo che la strega se ne andasse, o almeno dicesse esplicitamente cosa stesse cercando di ottenere da lui. Ma non osava chiederglielo di persona, e intanto taceva, mentre fuori ricominciava a nevicare.
Una neve sterile e sottile cadeva dal cielo, e andava a posarsi sul manto più compatto delle nevicate precedenti. Nella notte, anche quei fiocchi freschi si sarebbero ghiacciati, rendendo il lastricato del cortile e delle strade un’unica lamina scivolosa. I soldati di Camelot non avrebbero potuto usare i destrieri ancora per alcuni giorni.
«Morgana ama la neve» proruppe la donna, d’improvviso.
Uther rimase sorpreso da questa sua affermazione fuori luogo. «Non ne ero a conoscenza…».
«Perché non le presti abbastanza attenzione. Così tanto impegnato a combattere la magia! La tua figliastra sta crescendo, e il tuo unico pensiero è che sia viva come avevi promesso a suo padre».
«Basta!» rispose infuriato, interrompendola, «non puoi venire qui a rimproverarmi per quel che decido di fare, né tanto meno se ciò interessa Morgana».
«Che maleducato… nemmeno a saper reggere una conversazione normale. Bene, Uther, sta’ attento. Per Yule, domani su Camelot…» cominciò a proferire la donna.
«Taci, strega!» l’uomo le si fece vicino con fare minaccioso.
«Domani, su Camelot, nevicheranno incantesimi».
Nimueh scomparve, e così anche l’ultimo urlo disperato del re si perse dietro i fumi della sua promessa di dono. «Sta’ lontana da mia figlia».
Ma la donna era già distante, chissà dove. Uther si lasciò cadere sul letto, affondando nella morbidezza del materasso. Ogni sera, sentirlo così vuoto gli ricordava Ygraine, e, ogni sera, una lacrima solitaria gli solcava il volto. Stavolta, nella stessa goccia d’oceano, due volti femminili si condividevano il dolore del re. Ygraine, Morgana, Ygraine. Maledetta Nimueh.
“Don't shed a tear for me
I stand alone
This path of destiny
Is all my own
Once in the hands of fate
There is no choice
An echo on the wind
You'll hear my voice...”
[Non lasciar cadere una lacrima per me
Io resisto da sola
Questo sentiero del destino
È tutto mio
Una volta nelle mani del fato
Non c’è scelta
Un’eco nel vento
Sentirai la mia voce...]
Si sentì il dolce suono di un paio di calici che si scontravano fra loro. Il rumore dilagò per la grotta come un liquido versato su un tappeto, impregnando ogni fessura della sua voce cristallina e felice. Le stesse gemme vermiglie, incastonate sul manico in vetro, spandevano la loro calorosa luce. Un richiamo che, lento, veniva sussurrato di candela in candela, di torcia in torcia, ogni fiamma che tremolava quasi stesse cantando la stessa melodia delle altre.
L’antro era, per una volta l’anno, luminoso e caldo, benché restasse per lo più spoglio com’era sempre stato. Pareva però aver abbandonato la sua veste sobria e melanconica, cercando di preservare la scintilla del Sol Invictus e cullandosi in essa.
Nimueh era seduta in braccio a un uomo e reggeva con una mano un bicchiere colmo di vino rosso, mentre con l’altra attorcigliava al dito i ricci biondo cenere del compagno. Sorridevano entrambi, sorseggiando ogni tanto dalla coppa.
«Il fuoco ha deturpato il tuo viso, Edwin… ma l’altra metà è di una bellezza esasperante».
«Se mi vedessi con altri occhi, non diresti così» il giovane poggiò il calice su un tavolino di legno appena sbozzato che giaceva affianco alla poltrona dove erano seduti. Dicendo questo, il suo volto s’adombrò un poco, gli occhi verde chiaro trapassati da un bagliore del fato, dalle fiamme del passato.
«È una bellezza solo mia» Nimueh si avvicinò alla guancia piagata di Edwin, e vi diede un bacio soffuso d’amore. «Der Shöwel» sussurrò dopo.
Una lastra tersa comparve davanti agli occhi del giovane, tremolando come fosse acqua di fonte. L’incantesimo della Sacerdotessa rifletteva un uomo d’immane fascino, cosparso di un’avvenenza regale, incantevole. Con l’ingannevole magia, Nimueh aveva fatto scomparire per poco le cicatrici lasciate dall’incendio in cui Edwin era stato coinvolto, e ora gli mostrava in quella specchiera come era bello, magnifico, se solo avesse messo da parte una volta per tutte quel tragico incidente.
«Ti ho sempre detto che non voglio tornare com’ero,» con lo sguardo, Edwin percorreva le sue forme lisce che si riproducevano nello schermo marino, erano delicate, inconsuete per lui. Gli sembrava d’esser tornato fanciullo. Aggiunse: «non voglio… non voglio mostrare di essere sopravvissuto così alle crudeltà di Uther».
«Amore, Uther prima o poi morirà».
«Ma ciò che ha fatto vivrà per sempre. E se lui deve morire… che lo faccia per mano di chi cerca pura vendetta». Edwin passava la sua mano sulla schiena arcuata della strega, sentendo il gelido tatto della sua pelle attraverso la veste sottile. L’incantesimo intanto sfumò come una bacchetta d’incenso, lentamente.
«Partirai per Camelot» lo rimproverò lei, allontanandosi a stento e facendo presa sui manici di velluto della sedia, il riverbero di quella scelta che le offuscava i pensieri.
«Sì, Nimueh. Solo così potrò far tacere i miei incubi». La decisione era chiara sul suo volto, ritornato quello oscuro di un tempo, le labbra strette in una smorfia di risolutezza.
«Ma puoi far smettere le anime che ti tormentano! La vendetta non è nel tuo cuore: è quella che loro t’impongono. Cacciali, e sarai libero».
«Libero come Uther? Non si merita un giorno di vita in più».
«Altri faranno il lavoro sporco al posto tuo… potrei provarci io. Ci ho già provato». Gli occhi della donna manifestavano apprensione per il giovane.
«E hai fallito». Edwin voltò lo sguardo verso una torcia appesa sulla parete opposta, dove ombre di forme arcane s’intersecavano alle rientranze e alle fratture della volta in roccia. Racchiuse un po’ del rimorso nel suo cuore, e più dolcemente si rivolse a lei: «I miei genitori sono morti in quell’incendio, e per poco non feci la stessa fine anch’io. Nimueh… sono loro che cercano pace nella vendetta. Posso rifiutare la pace a chi mi ha dato per primo la vita?»
Ma fu una domanda che rimase senza risposta. Il silenzio scese fra loro: Nimueh semplicemente si strinse al petto di lui, l’emozione che le sconquassava le membra. A lungo aveva cercato, con diversi espedienti, di eliminare Uther e di inseguire lei stessa quel soave piacere della rivalsa. Ma mai, mai si era arrischiata a mettersi così in luce come Edwin aveva deciso di osare. Con Merlin a corte, pronto ad ostacolare ogni suo intervento com’era accaduto in precedenza per lei, poteva davvero perderlo. E saperlo le doleva il petto e le squarciava l’anima.
Affondò il viso fra i sui ricci, baciandone il collo profumato di gardenia e acqua sorgiva, pelle fresca che pulsava di vita. Sentì le braccia di lui legarsi attorno alla sua vita, e avvicinarla ancora di più, stringendola in un abbraccio impetuoso. Le loro labbra si cercarono, gli occhi chiusi, per perdersi in un istante d’eterno fra le onde della passione.
“So when you think of me
Do so with pride
Honor and bravery
Ruled by my side
And in your memory
I will remain
I will forever be within the flame...”
[Così quando penserai a me
Fallo con orgoglio
Onore e coraggio
Schierati dalla mia parte
E nella tua memoria
Io resterò
Sarò per sempre all’interno della fiamma…]
Gli aveva regalato una lanterna. Di tutti i baci, i doni, gli incantesimi che avrebbe potuto dargli, lei gli aveva donato solo una lanterna.
Yule, la luce… il simbolo del sole che rinasce sull’oscurità. Un simbolo di vittoria. E la lanterna avrebbe significato questo: un lucore affettuoso che dondolava leggero nella sua intelaiatura in ferro, e che l’avrebbe guidato come uno stendardo portatore di salvezza. O, più semplicemente, portatore di una speranza di salvezza.
Finché la lingua di fuoco avrebbe sfavillato a indicare la via, Nimueh sapeva che il suo cuore sarebbe stato con lui. Le rinvennero alla mente le parole che, quella sera prima, aveva detto a Uther. Sai che a Yule noi Sacerdotesse della Religione Antica usavamo fare dei doni?
Quella stessa notte, quando Edwin si era preparato per partire alla volta di Camelot, il suo spirito di Sacerdotessa aveva preparato il dono della lanterna. Lui le aveva sorriso dolcemente, e aveva accolto quella manifestazione di cura con una delle tante appassionate effusioni d’amore che si erano scambiati in quelle ore. La strega già sentiva la mancanza di quell’aria pervasa di gardenia, e la sua grotta ora era impregnata dalla solitudine, la stessa che si era insinuata nel suo cuore.
Le fiamme delle torce e delle candele erano tornate color ghiaccio, l’unica fonte di colore più vera rivelata dal suo abito rosso scuro. Dalle sue labbra, che soffrivano la mancanza di carne da agguantare, e che diventavano man mano più gelide, pietrificate in un’espressione impura.
Il momento di preparare il dono per Uther era arrivato. Con questo, sperava di poter quanto meno spianare la strada ad Edwin.
Erano già alcuni minuti che Nimueh camminava avanti e indietro nella sala adibita a preparare magie, il mantello che aveva indossato quella mattina che frusciava a contatto col terreno ruvido. Non era altro che una stanza circolare dalla volta a cupola, priva di sbocchi verso l’esterno e con i muri stipati di tavoli, armadi e librerie in legno di diverse altezze. Al centro, si stagliava la fonte con cui prevedeva e osservava ciò che accadeva a Camelot, caratterizzata da un alto piedistallo e un vaso in granito poggiato sopra. Entrambi erano decorati con motivi floreali intersecati a rune e segni magici che contribuivano a far apparire le visioni nel recipiente. In quel momento, però, l’acqua era torbida e piatta, calma, e non mostrava alcunché.
La furia continuava a crescere all’interno della donna. Prima flebile, appena emersa sotto la cappa di una tranquillità all’apparenza impassibile, poi più potente, stravagante, con culmini e discese improvvise. Ad esse, si accompagnavano istanti di lucidità in cui l’idea di un “dono” speciale si formava nella sua mente, come un pupazzo di neve in una fredda giornata, la cui bellezza si può ammirare solo una volta che il lavoro è concluso.
Così, una volta che fu sicura di ciò che stava per fare, si diresse spedita verso il centro della sala. Una profezia, una sorta di piccolo gioco, in cui Nimueh sarebbe stata giudice e regina, creatrice di distruzione.
«Mieror, de’filäch, naström chiåner» dalle sue dita scorsero fiocchi di neve e spicchi di specchi, che cadendo incresparono le acque della conca, da cui furono inghiottiti. Ora una lieve corrente d’aria opaca si muoveva in circolo appena sopra il livello del liquido, formando su di esso delle piccole onde agitate.
«Mieror, necht vebeyr». Una fiamma nacque sul catino e ne percorse velocemente i bordi in pietra, un riverbero viola che s’accese di vigore e che in pochi istanti implose su se stesso, spegnendosi senza alcun rumore e filamento di fumo. L’unico ricordo che rimase di esso fu il suo colore, che ancora si diffondeva violaceo come il mantello della Sacerdotessa.
«Bene, Uther. Il mio dono è compiuto» disse compiaciuta, gli occhi blu oltremare che scrutavano nella sua singolare finestra su Camelot, «chiunque calpesterà il segno di Nimueh, morirà per mano di un mago».
«E ora vediamo come se la passano in città».
La prima immagine che comparve fu quella del cortile interno al castello, illuminato da sparuti raggi di sole che perforavano la coltre di nuvole da nevischio, nonostante fosse già il crepuscolo, e che venivano estesi dallo spesso strato di neve che ricopriva il lastricato. L’impressione che si aveva, osservando bene l’aria, era che nevicasse ancora. Però i fiocchi erano spessi; talvolta, fra miliardi e miliardi di piccole gocce di ghiaccio, comparivano striature più luminose e ampie, dall’aspetto affilato.
Quadrati di forme diverse che si abbattevano al suolo, atterrando in un suono attutito che si confondeva fra lo spirare del vento e i suoi gelidi sospiri. Nessuno si sarebbe accorto presto di ciò che il cielo mandava: incantesimi, magia. La profezia di Nimueh.
Dalla porta principale del palazzo, si precipitò in strada una fanciulla stretta in un mantello verde smeraldo. Scese pochi scalini della lunga scalinata, quindi si fermò. La giovane, dalla pelle pallida quasi quanto il manto nevoso, si levò subito il cappuccio dal viso, per rivolgerlo in alto. Non si preoccupava del freddo che le inumidiva le guance e le impiastricciava i lunghi capelli, bensì respirava ad ampi tratti, il petto che sotto le vesti si alzava e abbassava visibilmente. Un sorriso le increspava il volto, un sorriso felice, soddisfatto, finalmente in pace.
Era sola. Nimueh sapeva di chi si trattava, poiché quei tratti le erano rimasti impressi nella mente. La pupilla del re, Morgana, una ragazza così promettente, con i suoi sogni premonitori… di sicuro con un futuro intriso di stregoneria.
Le dispiaceva promettere una fine a una donna che, in fondo, faceva parte del suo stesso schieramento. Ma una conquista desidera un prezzo, una vita per una vita. E la Sacerdotessa restò impassibile quando un coccio di specchio piovuto dal cielo lasciò una scia rossa sulla guancia della giovane.
Morgana si riscosse dal suo stato di beatitudine, e abbassò lo sguardo per vedere cosa le avesse provocato quella ferita. Intanto una goccia di rubino, come una triste lacrima, scendeva lenta lungo la sua pelle. S’inginocchiò senza preoccuparsi di asciugarla, attratta da un riflesso più intenso che si propagava da uno scalino più in basso. Prese in mano il frammento, e se lo rigirò lentamente fra le dita. Il bordo era affilato, dalle punte acuminate come lance e spade, armi vere e proprie. Sembrava che stesse riflettendo, e che pensasse che non ci fosse motivo perché oggetti del genere stessero cadendo giù dal cielo.
Un simbolo era quasi inciso sulla facciata della scheggia, su cui si percepiva al tatto l’incavatura dell’intarsio. Pareva una runa, con due V sovrapposte, di cui una al contrario, che formavano un rombo da cui fuoriuscivano per un po’ le linee. All’interno di esso, un puntino appena percettibile. Dalla polla d’acqua, Nimueh vide Morgana rialzarsi in piedi e accorgersi che l’intero cortile pareva cosparso di piastrine di specchi.
La figliastra del re fu striata da un nuovo pezzo passatole sul fianco, e che sdrucì il mantello senza lasciarle apparenti ferite. La giovane rientrò immediatamente nel castello, portando il primo frammento con sé.
Nimueh era soddisfatta. Chiunque fosse rimasto ferito, anche solo graffiato, da uno di quelli specchi, aveva il futuro già scritto: marchiato, con il suo simbolo, che lo predestinava a morire per mano di uno stregone. Non importava chi quest’ultimo fosse, ma sarebbe stata la magia, e solo questa, a staccare la vita dal suo corpo, per sempre.
La Sacerdotessa restò ancora a scrutare all’interno della sua polla, interessata agli sviluppi della vicenda. Morgana era stata la prima, ma chi, poi, l’avrebbe seguita? Non ci fu tempo di riformulare il pensiero, che manipoli di guardie comparvero, in piccoli gruppi, dalle varie uscite del castello. Probabilmente la ragazza aveva, una volta tanto, deciso di interpellare subito il padre sull’accaduto.
Uno, due soldati furono presi di sorpresa, e graffiati dalle punte acuminate attraverso la cotta di maglia. Altri tre ebbero il viso striato da un taglio sottile. Non parevano preoccuparsene, solo si precipitarono all’esterno della corte per perseguire chiunque sembrasse essere l’artefice di tutto ciò.
Ogni persona dilaniata dagli specchi era una vita in più per il suo animo avido di morte, e la gioia s’effondeva in Nimueh. Solo di una cosa provava ancora rancore: Uther non era uscito a perlustrare il territorio, quindi non pareva essere passato sotto la sua profezia. Temeva che ricollegasse la loro discussione all’avvenimento prima di poter anche rimanere minimamente scalfito dal suo dono.
«Un peccato… un peccato che colui cui ho preparato il mio tenero regalo non possa sperimentarlo egli stesso».
Ma la strega non poté soffermarsi oltre, rifletterci ancora. Un malessere la percosse tutta, e fitte lancinanti sembravano volerle perforare la testa. Un formicolio le attraversò le mani, facendole tremare. Andò nell’altra stanza, per sedersi un attimo sulla stessa poltrona rivestita in velluto verde su cui soleva stare con Edwin.
La posizione seduta non agevolò però il suo malore, che continuò ad acuirsi, tanto che ogni briciolo di lucidità le abbandonò le membra. Tanto che lei stessa perse conoscenza, accasciandosi sulla seggiola, gli occhi blu dalle pupille dilatate, enormi, e che la facevano sembrare preda di una follia o posseduta da un demone. Ma le sue mani ora erano immobili, completamente prive di forza vitale, le braccia sottili da cui s’intravedevano le vene violacee appoggiate sgraziatamente sui braccioli della sedia. Nimueh era diventata una statua di dolore, in cui lo spirito si era staccato dal corpo.
Nell’altra mente, nell’altro mondo, una visuale si faceva largo nella nebbia di un’anima ingabbiata dal fato. Una visione indigesta, non voluta, ma che gli occhi del cuore miravano a continuare a vedere. Forse gli Spiriti della vita e della morte avevano richiamato, anche solo per pochi istanti, la loro Sacerdotessa. Così, per mostrarle, e farle vedere, qualcosa di cui avrebbe potuto pentirsi per l’eternità. E lei vide…
Edwin camminava lungo il freddo sentiero che guidava alle porte di Camelot. Nella sua mano era stretta la lanterna di Nimueh, accesa anche se fosse pieno dì. Erano passati un paio di giorni da Yule, e lui, armato della sua forza di volontà, era giunto a piedi fino al luogo del suo premeditato delitto. La neve si era sciolta, e un sole rischiarava di poco dall’alto del cielo.
L’uomo entrò con passo deciso nella città, e percorse i suoi viali diretto al castello, trascinandosi con la fatica del viaggio lungo le intricate strade dei bassifondi. Il suo sguardo… così forte, vigoroso, così meraviglioso se nascosto dal mantello da viaggio, s’illuminava nell’ombra gettata dal cappuccio.
D’un tratto inciampò con i suoi sandali in qualcosa di spigoloso che non aveva notato, e incespicò un po’, ma non cadde. Un’imprecazione gli sfuggì di bocca quando vide la lanterna evadere dalla sua stretta e precipitarsi in terra, i vetri sottili che attorniavano la fiamma spaccati in miriadi di fini frammenti. Il fuocherello al suo interno si spense quasi contemporaneamente, sfrigolando appena. Mentre cercava di riprendere l’equilibrio, zoppicando per alcuni passi, l’uomo cercò con lo sguardo cosa fosse stata la causa di quel piccolo incidente. Individuò un frantume di specchio, ma gli aveva solo arrossato l’alluce, non protetto dai semplici sandali aperti che indossava.
Edwin continuò il suo cammino, abbandonando la lanterna in terra, ormai inutile.
Gli sarebbe mancato, il cuore di Nimueh… ma lui sarebbe sopravvissuto per riaverlo ancora, più vicino di quanto non gli fosse mai stato.
Intanto Yule, negli ultimi strascichi della sua festività, aveva preso il suo ultimo tributo di sangue.
“Now at the journey's end
We've traveled far
And all we have to show
Are battle scars
But in the love we shared
We will transcend
And in that love, our journey never ends...”
[Ora alla fine del viaggio
Noi abbiamo viaggiato lontano
E tutto ciò che abbiamo da mostrare
Sono le cicatrici di battaglia
Ma nell’amore che abbiamo condiviso
Noi trascenderemo
E in quell’amore, il nostro viaggio non finirà mai…]


Lettori fissi
Etichette

La mia Libreria
- Cronache del Mondo Emerso
- Le Guerre del Mondo Emerso
- Leggende del Mondo Emerso
- Le Creature del Mondo Emerso
- Guerre del Mondo Emerso - Guerrieri e Creature
- Wojny Świata Wynurzonego - Sekta Zabójców
- I Regni di Nashira
- Favole degli Dei
- High Voltage Tattoo
- The Tattoo Chronicles
- Encyclopedia Gothica
- White: A Decade
- Arlene's Heart
- Favole
- Misty Circus
- Graceling
- Fire
- Fallen
- Torment
- Passion
- Rapture
- Fallen in Love
- Il Bacio dell'Angelo Caduto
- My Land
- La Sedicesima Luna
- La Diciassettesima Luna
- La Corsa delle Onde
- I Lupi di Mercy Falls
- La Saga del Lupo
- Esbat
- La Profezia delle Inseparabili
- Black Friars
- Il Sangue di Faun
- Gli Eroi del Crepuscolo
- La Strada che Scende nell'Ombra
- La Leggenda di Earthsea
- La trilogia di Sevenwaters
- Il Ciclo dell'Eredità
- Harry Potter
- Queste Oscure Materie
- Alice nel Paese della Vaporità
- Il Signore degli Anelli
- Il Silenzio di Lenth
- Il Risveglio delle Tenebre
- La Guerra Degli Elfi
- Artemis Fowl
- I Guardiani della Notte
- La Scacchiera Nera
- L'Ombra Del Guerriero
- Il Ciclo di Shannara
- Cronache del Ghiaccio e del Fuoco
- La Leggenda di Otori
- Le Cronache di Spiderwick
- Le Cronache di Narnia
- Reckless, lo specchio dei mondi
- Septimus Heap
- L'Alchimia di Nina
- La Bambina della Sesta Luna
- La trilogia di Geno
- Morga, la Maga del Vento
- La Ragazza Drago
- Tiffany e i Piccoli Uomini Liberi
- Un Cappello Pieno di Stelle
- Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori
- Il Libro del Drago
- Fairy Oak
- I Misteri di Fairy Oak
- Arthur e il popolo dei Minimei
- Coraline
- Il Figlio del Cimitero
- Stardust
- Timeline
- La Fine del Mondo e il Paese delle Meraviglie
- 1Q84
- La Ragazza Fantasma
- Io & Dewey
- Io & Marley
- Luisito, una storia d'amore
- L'Arte di Correre Sotto la Pioggia
- L'anno della lepre
- Chocolat
- Le Scarpe Rosse
- Cinque Quarti d'Arancia
- Vino, Patate e Mele Rosse
- La Scuola dei Desideri
- Le Parole Segrete
- Il Seme Del Male
- Il Ragazzo Con Gli Occhi Blu
- Profumi, Giochi e Cuori Infranti
- La Lettrice Bugiarda
- La Ragazza Che Rubava Le Stelle
- La Casa dei Mai Nati
- La Biblioteca dei Morti
- Il Colore del Sole
- L'Ombra del Vento
- Il Gioco dell'Angelo
- Marina
- Le Luci di Settembre
- Il Palazzo della Mezzanotte
- Il Prigioniero del Cielo
- Crypto
- Angeli e Demoni
- Il Codice Da Vinci
- Il Simbolo Perduto
- Snow Flower And The Secret Fan
- Memorie di una Geisha
- Sašenka
- Ai Piani Bassi
- La Bambinaia Francese
- Mille Splendidi Soli
- Il Cacciatore di Aquiloni
- Beautiful Malice
- Le ho mai raccontato del vento del Nord
- La Settima Onda
- Per Non Dirle Addio
- Ricordati di Guardare la Luna
- Quando Ho Aperto gli Occhi
- A Voce Alta - The Reader
- Pastorale Americana
- Miles Gloriosus
- Aulularia
- Eunuchus
- Phormio
- La Favola di Eros e Psiche
- Saffo - Poesie
- Decameron
- Elogio della Follia
- La Locandiera
- L'Ingannatore di Siviglia
- La Vita è Sogno
- Shakespeare - Tutto il Teatro
- Don Chisciotte della Mancia
- Lettere a un giovane poeta
- Il Piacere
- Il Fuoco
- Le Vergini delle Rocce
- L'Innocente
- La Lettera Scarlatta
- Le Affinità Elettive
- Madame Bovary
- Educazione Sentimentale
- La Vergine e lo Zingaro
- Moll Flanders
- Sherlock Holmes
- Il Ritratto di Dorian Gray
- Notre-Dame de Paris
- Il Conte di Montecristo
- I Tre Moschettieri
- Ragione e Sentimento
- David Copperfield
- Il Giovane Holden
- 1984
- Dracula
- Carmilla
- M. R. James - Tutti i racconti di fantasmi
- Lovecraft - La tomba e altri racconti dell'incubo
- Poe - Il Corvo e tutte le poesie
- Magick






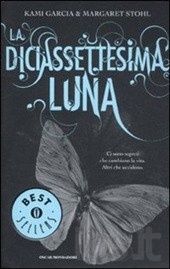



.gif)
